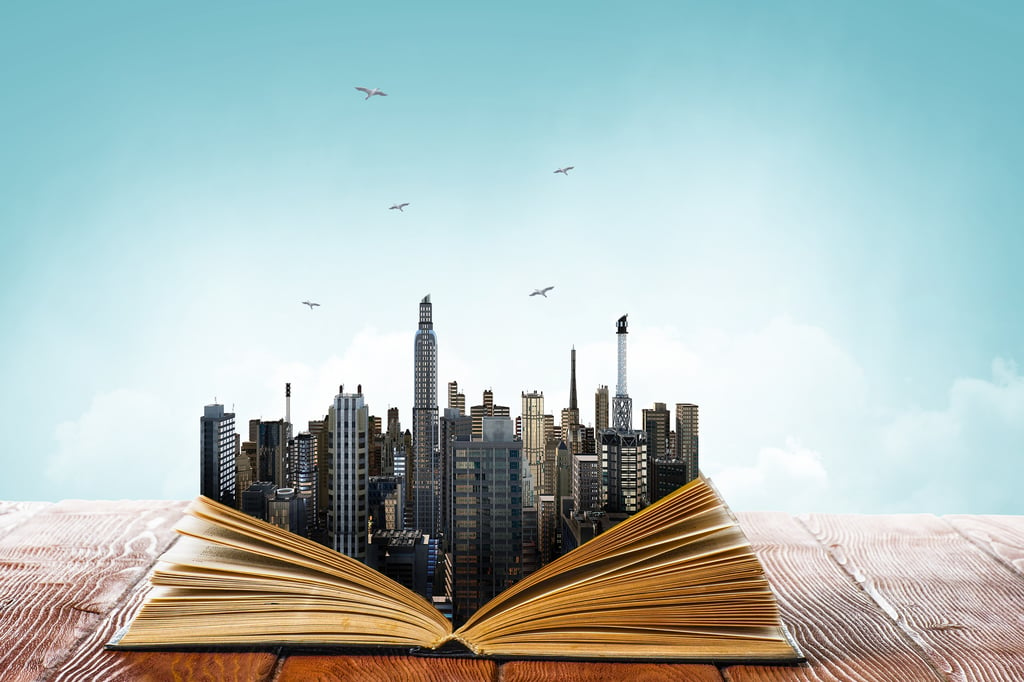Valutare il comportamento all’Esame di Stato
Educazione civica: tra scelte individuali e responsabilità collettiva
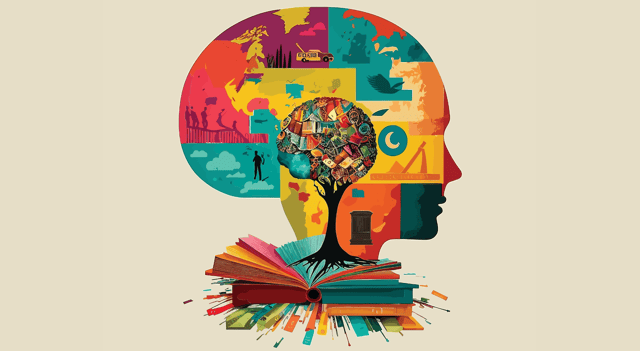
L’Esame di Stato si avvicina e così anche il tema della valutazione sotto il cappello dell’Educazione civica. Valutare il comportamento è un aspetto delicato: riguarda sia il diritto dei giovani alla libertà di espressione, che va salvaguardato nel processo di maturazione delle loro personalità, sia le norme generali e i regolamenti specifici della comunità scolastica, che vanno conosciuti e rispettati.
La cronaca racconta spesso di episodi di violenza e di mancato rispetto verso singole persone, istituzioni, luoghi e oggetti, di cui alcuni giovani risultano protagonisti: vandalismo verso strutture e attrezzature scolastiche, bullismo e cyberbullismo, razzismo, misoginia e omofobia nei confronti di coetanei e adulti, fino a gravissimi delitti, quali i femminicidi.
Il comportamento dei giovani all’attenzione dell’opinione pubblica
Il fenomeno desta allarme sociale in Italia (come in altre parti del mondo) non tanto perché coinvolga un numero molto alto di giovani – anzi la maggioranza di essi adotta comportamenti corretti e in molti casi lodevoli – quanto perché appare la spia di un malessere generazionale e di una tendenza che potrebbero avere esiti peggiori e perché assume oggi connotazioni specifiche rispetto al passato.
Tra queste vi è l’utilizzo dei mezzi digitali, in particolare dei social network, come contesti di origine e di applicazione e come amplificatori dei loro effetti.
Inoltre – altro aspetto caratterizzante l’attualità – risulta scarsa la collaborazione tra istituzioni scolastiche e famiglie, le quali spesso si trovano disorientate di fronte ai comportamenti dei propri figli e delle proprie figlie, abdicano all’autorevolezza genitoriale e tendono a individuare negli insegnanti una controparte piuttosto che ricercarne un’alleanza educativa.
Di tutto ciò danno testimonianza non soltanto gli articoli e i servizi giornalistici sia di cronaca sia di opinione, ma anche testi di narrativa e di saggistica, che descrivono e interpretano situazioni del genere, e film e serie TV, come il recente Adolescence di Netflix, che narra un caso di femminicidio da parte di un adolescente inglese e che sta destando un vivace dibattito a livello mondiale.
In tale contesto si situano alcune recenti iniziative del Ministero dell’Istruzione (MIM) riguardanti il comportamento di studentesse e studenti in ambiente scolastico.
Ripartiamo dall’Educazione civica
Al comportamento di studentesse e studenti in ambiente scolastico fanno ampio riferimento le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica emanate nel 2024 (allegate al DM n.183), che insistono sui concetti della responsabilità individuale, del rispetto di regole e norme, sulla salvaguardia dei diritti delle persone, sui valori della partecipazione e della solidarietà, nei contesti di convivenza sociale e di vita quotidiana in famiglia e a scuola.
Secondo la normativa vigente sugli Esami di Stato, le competenze trasversali di Educazione civica acquisite di studentesse e studenti costituiscono oggetto di verifica durante il colloquio, che, a partire dal 2024, ha assunto una gestione più personalizzata e aderente alle caratteristiche individuali della persona candidata, offrendo la possibilità di affrontare anche in quella sede questioni attinenti al proprio o altrui comportamento.
La nuova Legge sulla Valutazione e sul voto di comportamento
Al comportamento rimanda anche la nuova Legge sulla Valutazione (L. 150/2024), che affronta la questione del “voto di condotta”, riprendendo la precedente normativa e in parte modificandola in senso restrittivo, al fine – si afferma – «di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti […], di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti» (art. 4).
Tra le novità riguardanti le scuole superiori emerge la “sospensione” della promozione alla classe successiva per coloro che nello scrutinio finale abbiano ricevuto il voto di comportamento di 6 decimi, ai quali viene richiesta la redazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da discutere (e valutare) a settembre.
Analogamente, l’assegnazione di tale elaborato è condizione per l’ammissione all’Esame di Stato per studentesse e studenti delle classi quinte con 6 decimi di comportamento, con l’obbligo di redigerlo e discuterlo in sede di colloquio (come ribadito nell’OM 67 sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato dell’a. s. 2024/2025).
Comportamento individuale e rispetto delle regole e delle norme
Il tema del comportamento e della relativa valutazione scolastica è delicato.
Da una parte esso investe il diritto dei giovani alla libertà di espressione, che va salvaguardato nel processo di maturazione delle loro personalità. Dall’altra rimanda alle norme generali (Costituzione e leggi) e ai regolamentispecifici della comunità scolastica in cui si opera, che non vanno infranti, ma anzi conosciuti e rispettati.
Nell’equilibrio tra le due istanze si colloca il compito degli insegnanti, chiamati a riconoscere eventuali situazioni critiche nella classe, a esprimere e far rispettare l’autorevolezza del proprio ruolo e, nel caso di infrazioni alle regole, contribuire (insieme agli altri organi della scuola) a valutarle ed eventualmente sanzionarle.
Attività didattiche sul comportamento
Ma il ruolo docente si esprime soprattutto nell’azione didattica ed educativa e nella capacità di trasmettere, attraverso e insieme ai contenuti delle proprie discipline, i valori costituzionali di rispetto delle persone, nelle loro specificità, e di solidarietà e impegno per la collettività, e di favorire in ogni studente l’assunzione di tali responsabilità secondo le proprie caratteristiche personali.
A ciò rimandano (come già accennato) le Linee Guida per l’Educazione civica che, tra le competenze e gli obiettivi di apprendimento, indicano:
- «sviluppare atteggiamenti e adottare comportamenti fondati sul rispetto verso ogni persona, sulla responsabilità individuale, sulla legalità, sulla partecipazione e la solidarietà…»;
- «rispettare le regole e le norme…, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, …al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, …per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone…»;
- «individuare forme di comunicazione digitale adeguate, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo…».
A questo riguardo, in particolare, si vedano i Nuclei concettuali di “Costituzione” e “Cittadinanza digitale”, con i relativi obiettivi e competenze, oggetto di verifica in sede di colloquio d’esame.
Anche l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, richiesto agli studenti scrutinati con il 6 di comportamento per essere discusso prima dell’avvio dell’anno scolastico successivo o in sede di colloquio d’esame, rappresenta un’attività didattica in cui è fondamentale l’interazione tra docenti e discenti.
Referenze iconografiche: JMGDigital/Shutterstock