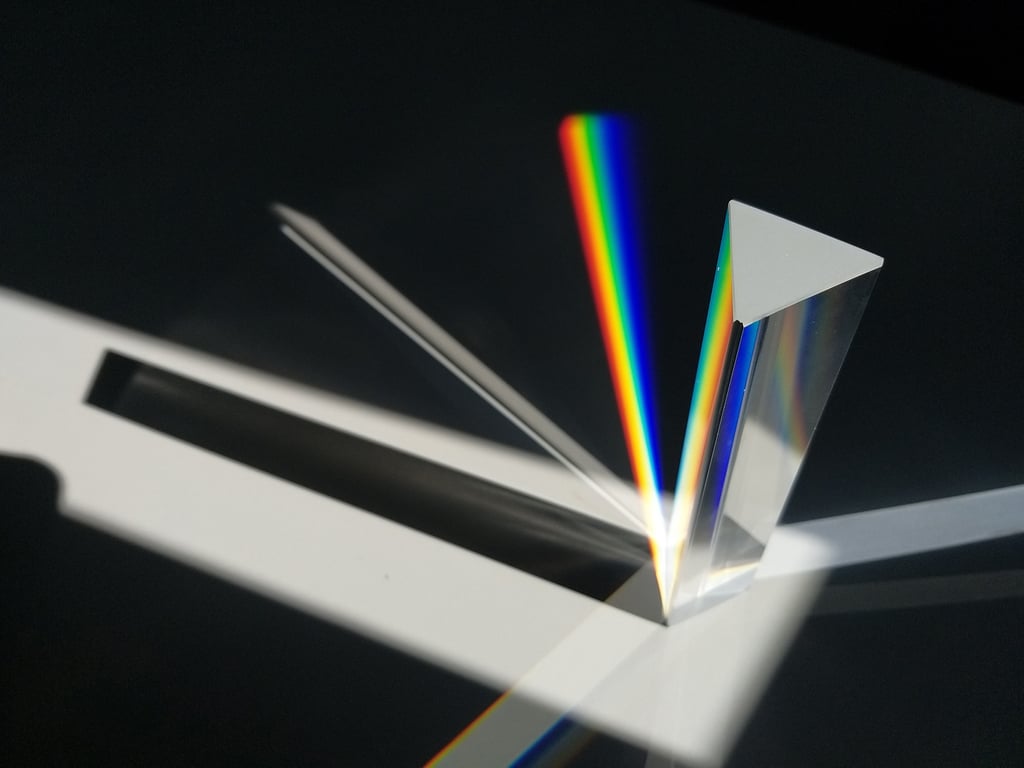Al pari della fisica e della chimica, anche la biologia può essere messa al servizio dell’arte e della conservazione dei beni culturali. Come? Per esempio sfruttando le caratteristiche di certi microrganismi, come i batteri, che si sono dimostrati abili restauratori. Parliamo, ovviamente, di specie non pericolose per la salute e che posseggono abilità particolari: per esempio “mangiare” le patine di sporco che si depositano nel tempo sulle opere d’arte oppure produrre (precipitare, in gergo) sali minerali che vanno a rinforzare sculture, architetture e manufatti in pietra. In effetti, l’applicazione della biologia alle tecniche di restauro si divide in questi due rami: la biopulitura e il bioconsolidamento. Scopriamo di cosa si tratta.
Un impacco di batteri
![]() A ipotizzare l’impiego dei microrganismi per il restauro dei beni culturali furono due inglesi, Anne Moncrieff e Kenneth Hempel del Victoria and Albert Museum di Londra. Era il 1970, e i due restauratori avevano intuito che alcuni ceppi di batteri avrebbero potuto “mangiare” le cosiddette croste nere che spesso si formano sui monumenti. Cominciarono così a presentare ai convegni internazionali la loro idea di un “impacco biologico” (biological pack) da applicare ai marmi. Il primo vero studio di biorestauro arrivò, però, parecchio più tardi, alla fine degli anni Ottanta: quando Ronald Atlas (oggi docente di Biologia all’Università di Louisville, Usa) dimostrò che il batterio Desulfovibrio vulgaris poteva davvero ripulire il marmo, e senza causare alcun danno. Dopo 12 ore di trattamento, Atlas aveva ottenuto una pulitura parziale di una superficie: un risultato modesto, ma la prova sperimentale c’era. Da quel momento, restauratori e biologi hanno cominciato a ricercare i microrganismi più adatti da utilizzare nella pulitura di diversi tipi di materiali: non solo marmi, ma anche affreschi e dipinti murari, pitture su legno, libri e pergamene antiche, pellicole, lastre fotografiche, monete.
A ipotizzare l’impiego dei microrganismi per il restauro dei beni culturali furono due inglesi, Anne Moncrieff e Kenneth Hempel del Victoria and Albert Museum di Londra. Era il 1970, e i due restauratori avevano intuito che alcuni ceppi di batteri avrebbero potuto “mangiare” le cosiddette croste nere che spesso si formano sui monumenti. Cominciarono così a presentare ai convegni internazionali la loro idea di un “impacco biologico” (biological pack) da applicare ai marmi. Il primo vero studio di biorestauro arrivò, però, parecchio più tardi, alla fine degli anni Ottanta: quando Ronald Atlas (oggi docente di Biologia all’Università di Louisville, Usa) dimostrò che il batterio Desulfovibrio vulgaris poteva davvero ripulire il marmo, e senza causare alcun danno. Dopo 12 ore di trattamento, Atlas aveva ottenuto una pulitura parziale di una superficie: un risultato modesto, ma la prova sperimentale c’era. Da quel momento, restauratori e biologi hanno cominciato a ricercare i microrganismi più adatti da utilizzare nella pulitura di diversi tipi di materiali: non solo marmi, ma anche affreschi e dipinti murari, pitture su legno, libri e pergamene antiche, pellicole, lastre fotografiche, monete.
Italia in prima linea
L’Italia, con il suo immenso patrimonio storico e artistico, non poteva che essere un luogo di elezione per lo sviluppo di questo campo di ricerca, nel quale, non a caso, primeggia. Il primo biorestauro italiano è stato eseguito nel 2004 sull’affresco Conversione di S. Efisio e battaglia di Spinello Aretino, nel Camposanto Monumentale di Pisa. Gli affreschi del Camposanto erano stati danneggiati da un bombardamento nel 1944 e restaurati nel dopoguerra con una colla animale, che però stava causando rigonfiamenti, crepe e perdita di colore. Ergo, la colla andava rimossa, ma i metodi tradizionali non avevano dato i risultati sperati. Il problema è stato risolto proprio grazie un batterio, Pseudomonas stutzeri. A identificarlo come il candidato ideale, e a testarlo con successo, sono stati i microbiologi delle università del Molise e di Milano (in cui si trovano due dei centri di ricerca italiani più avanzati nel biorestauro).
Appena un anno dopo, sempre l’Università di Milano ha condotto il secondo esperimento, questa volta sul marmo del Duomo del capoluogo lombardo. Come nel primissimo test di Atlas, si trattava di rimuovere le croste nere e sono stati usati gli stessi tipi di microrganismi: Desulfovibrio desulfuricans e Desulfovibrio vulgaris. Oggi, a poco più di 10 anni di distanza, l’elenco delle opere d’arte italiane restaurate dai batteri conta circa un centinaio di voci, tra cui spiccano la Pietà rondanina di Michelangelo e i dipinti della Galleria Farnese, a Roma.
Micro-pulitori all’opera
Come fanno, esattamente, i microbi a ripulire le superfici delle opere? “Nel caso dei batteri usati per rimuovere le sostanze indesiderate organiche e inorganiche si tratta di sfruttare il loro naturale processo di respirazione”, risponde Francesca Cappitelli, docente di microbiologia all’Università di Milano, tra i pionieri italiani di biorestauro. “In pratica – continua Cappitelli – questi batteri trasformano le sostanze da rimuovere, che sono solide, in gas. Non c’è pericolo di inquinamento, perché questi gas sono già presenti naturalmente in atmosfera.”
![]() Prendiamo le croste nere: si formano perché gli ossidi di zolfo – che sono inquinanti atmosferici – interagiscono con il carbonato di calcio di cui è costituito il marmo. La reazione chimica dà luogo al solfato di calcio biidrato, che non è altro che gesso. Questo gesso, però, si scioglie e si ricristallizza in continuazione, inglobando le particelle nere carboniose presenti in atmosfera per via dell’inquinamento. “E qui entrano in gioco i batteri anaerobi come Desulfovibrio” spiega Cappitelli. “Questi microbi respirano i sali a base di zolfo e rilasciano in cambio acido solfidrico, che è un gas” (i batteri che presentano queste caratteristiche vengono detti solfato-riduttori, NdR). Nel caso delle colle animali, invece, si usano batteri aerobi che mangiano letteralmente i residui organici, grazie a un complesso di enzimi in grado di metabolizzarli. I batteri non sono gli unici organismi impiegati nella conservazione dei beni culturali: anche i microfunghi e certi lieviti possono svolgere un ottimo lavoro. Il microfungo Beauveria bassiana, per esempio, è in grado di trasformare i composti di corrosione del rame, responsabili del degrado chimico di alcuni oggetti in metallo, in una patina stabile (di ossalato di rame) che, per di più, protegge il metallo stesso dal deterioramento.
Prendiamo le croste nere: si formano perché gli ossidi di zolfo – che sono inquinanti atmosferici – interagiscono con il carbonato di calcio di cui è costituito il marmo. La reazione chimica dà luogo al solfato di calcio biidrato, che non è altro che gesso. Questo gesso, però, si scioglie e si ricristallizza in continuazione, inglobando le particelle nere carboniose presenti in atmosfera per via dell’inquinamento. “E qui entrano in gioco i batteri anaerobi come Desulfovibrio” spiega Cappitelli. “Questi microbi respirano i sali a base di zolfo e rilasciano in cambio acido solfidrico, che è un gas” (i batteri che presentano queste caratteristiche vengono detti solfato-riduttori, NdR). Nel caso delle colle animali, invece, si usano batteri aerobi che mangiano letteralmente i residui organici, grazie a un complesso di enzimi in grado di metabolizzarli. I batteri non sono gli unici organismi impiegati nella conservazione dei beni culturali: anche i microfunghi e certi lieviti possono svolgere un ottimo lavoro. Il microfungo Beauveria bassiana, per esempio, è in grado di trasformare i composti di corrosione del rame, responsabili del degrado chimico di alcuni oggetti in metallo, in una patina stabile (di ossalato di rame) che, per di più, protegge il metallo stesso dal deterioramento.
Trovare la combinazione opportuna
“Il punto è trovare la combinazione migliore”, dice Anna Rosa Sprocati, coordinatrice delle attività del laboratorio di Microbiologia ambientale e Biotecnologie microbiche dell’Enea Casaccia di Roma, un altro dei laboratori d’eccellenza: “Il microrganismo da utilizzare, infatti, va scelto in base a molti fattori: al tipo di materiale da trattare, al tipo di sporco e a tutti i precedenti interventi di restauro o di modifica che ha subìto l’opera. Ogni reperto è un caso a sé e molto spesso un procedimento già applicato con successo deve essere adattato a nuove condizioni.”
![]() Il gruppo di Sprocati può contare su una collezione di circa 500 batteri restauratori. “Questi ceppi sono stati isolati in ambienti estremi, come i luoghi contaminati o i siti di lavorazione mineraria, e presentano caratteristiche molto particolari”, continua Sprocati. “Vengono selezionati per la loro azione altamente selettiva e questo è un grande vantaggio nel restauro, perché garantisce che l’intervento sia mirato al deposito da eliminare, e che il materiale sottostante non verrà danneggiato. Noi studiamo ciascun ceppo e osserviamo la sua azione sui diversi possibili substrati. Non si scappa: ogni nuovo caso di biorestauro deve essere studiato e quasi sempre la procedura che ne deriva resta a livello sperimentale, cioè di ricerca. Il passo successivo sarebbe trasformare il prodotto della ricerca in un prodotto ‘pronto per l’uso’ ma ancora oggi esistono pochi brevetti e soltanto un prodotto commerciale italiano.” L’obiettivo, però, è di ampliare il più possibile l’impiego dei microorganismi perché si possano rimpiazzare i solventi, più aggressivi sulle opere e tossici per gli operatori e per l’ambiente, creando un mercato di nuovi prodotti “bio-based”. Sono molti gli studi in corso. Qualche esempio? Sull’eliminazione di patine carbonatiche con ceppi batterici scoperti nella Tomba di Mercareccia, nella Necropoli di Tarquinia, applicati sui dipinti murali della Casina Farnese; sulla pulitura di superfici artistiche deteriorate da patine grasse con batteri che producono bioemulsionanti, cioè una sorta di saponi; sulla pulitura della carta antica grazie a Ochrobactrum sp., un altro bravo mangiatore di colle animali.
Il gruppo di Sprocati può contare su una collezione di circa 500 batteri restauratori. “Questi ceppi sono stati isolati in ambienti estremi, come i luoghi contaminati o i siti di lavorazione mineraria, e presentano caratteristiche molto particolari”, continua Sprocati. “Vengono selezionati per la loro azione altamente selettiva e questo è un grande vantaggio nel restauro, perché garantisce che l’intervento sia mirato al deposito da eliminare, e che il materiale sottostante non verrà danneggiato. Noi studiamo ciascun ceppo e osserviamo la sua azione sui diversi possibili substrati. Non si scappa: ogni nuovo caso di biorestauro deve essere studiato e quasi sempre la procedura che ne deriva resta a livello sperimentale, cioè di ricerca. Il passo successivo sarebbe trasformare il prodotto della ricerca in un prodotto ‘pronto per l’uso’ ma ancora oggi esistono pochi brevetti e soltanto un prodotto commerciale italiano.” L’obiettivo, però, è di ampliare il più possibile l’impiego dei microorganismi perché si possano rimpiazzare i solventi, più aggressivi sulle opere e tossici per gli operatori e per l’ambiente, creando un mercato di nuovi prodotti “bio-based”. Sono molti gli studi in corso. Qualche esempio? Sull’eliminazione di patine carbonatiche con ceppi batterici scoperti nella Tomba di Mercareccia, nella Necropoli di Tarquinia, applicati sui dipinti murali della Casina Farnese; sulla pulitura di superfici artistiche deteriorate da patine grasse con batteri che producono bioemulsionanti, cioè una sorta di saponi; sulla pulitura della carta antica grazie a Ochrobactrum sp., un altro bravo mangiatore di colle animali.
Batteri muratori: il bioconsolidamento
Anche l’intuizione di sfruttare i batteri per fortificare le opere in pietra non è nuova: risale a oltre 30 anni fa, quando si osservò che Bacillus cereus e Myxococcus xanthus erano capaci di produrre in laboratorio dei cristalli di calcite (carbonato di calcio). Questo fenomeno è noto come biomineralizzazione e oggi sappiamo che è molto comune tra i microrganismi. C’è almeno un vantaggio nell’usare i batteri calcinogeni per consolidare le opere in pietra carbonatico calcaree: la loro calcite (detta biocalcite) è più resistente e si integra meglio con il substrato rispetto a quella prodotta con i metodi più tradizionali.
Il primo test sul campo fu fatto nel 1999: un ceppo di Bacillus cereus (prelevato da una roccia carsica) fu letteralmente spruzzato sulla torre della Chiesa di Saint Medard (XII secolo) a Thouars, in Francia, su una superficie di circa 50 metri quadrati. Risultato? Il bacillo produsse uno strato superficiale di calce (di qualche micron) che ha consolidato la torre ed è rimasto stabile per almeno tre anni. Altri batteri come Myxococcus xanthus, grazie alla loro motilità, non colonizzano solo la superficie della pietra, ma penetrano al suo interno, attraverso i pori. Poiché servono alcuni giorni per ottenere il deposito di calcite, insieme ai batteri vengono spruzzate anche sostanze organiche, per esempio amminoacidi – di cui i microrganismi si nutrono. In alcuni casi, come nel Monastero di San Geronimo di Granada in Spagna, è stato osservato che è sufficiente – se non preferibile – applicare soltanto la soluzione nutritiva sulla pietra calcarea per stimolare la crescita dei microrganismi calcinogeni già naturalmente presenti e che, da soli, riescono a consolidare i monumenti.
Verso un mercato del biorestauro
Spagna e Francia sono in prima linea su questo fronte di ricerca, ma anche in Italia c’è fermento. “Nel corso degli ultimi anni, siamo riusciti a sintetizzare a bassi costi i componenti dell’acido aspartico, un amminoacido che può essere usato come precursore della biocalcificazione”, racconta Oana Cuzman, ricercatrice dell’Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC) del CNR. “Ancora, sotto la guida di Piero Tiano, pioniere della biocalcificazione in Italia, e insieme all’Università di Firenze, abbiamo individuato i geni coinvolti nel processo di precipitazione della calcite nel batterio Bacillus subtilis: grazie a questa scoperta, è stato possibile indurre la precipitazione di calcite senza ricorrere alle cellule batteriche vive. È molto importante continuare a studiare il ruolo ecologico dei microorganismi utilizzati per la conservazione dei beni culturali: questo ci permetterà di controllare sempre più nel dettaglio i processi e di immaginare un possibile mercato per il biorestauro.”
PER APPROFONDIRE ONLINE
- Biorestauro nei Musei Vaticani, atti di una giornata di studi tenutasi il 10 ottobre 2013.
- Ranalli G. et al., Biotechnology applied to cultural heritage: biorestoration of frescoes using viable bacterial cells and enzymes, “J Appl Microbiol”, 2005.
- Cappitelli F. et al., Advantages of using microbial technology over traditional chemical technology in the removal of black crusts from stone surfaces of historical monuments, “Applied and Environmental Microbiology”.