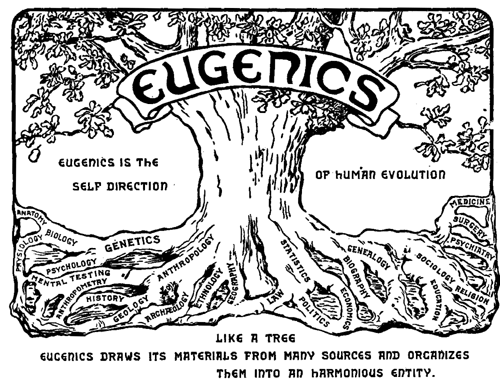Un ritratto dell’Italia del dopoguerra
«Isolamento dei luoghi, profondità delle tradizioni e delle culture, bellezza austera e luminosa dei caratteri fisici e umani»: questa era l’Italia che si allungava, piena di ostacoli geografici e disuguaglianze economiche, davanti agli occhi di Vasco Pratolini, improvvisato suiveur del Giro d’Italia, nel 1947. Le sue cronache ci restituiscono un ritratto vivido ed efficace dell’Italia di allora, alternando immagini di una realtà senza tempo, frammiste a quelle totalmente attraversate dalla febbre politica che segnava l’attualità dell’immediato dopoguerra. Così, in una Val Trebbia «tutta svolte e dirupi, con la natura da paradiso, con le strade da girone infernale», Pratolini si imbatte «in paesi che si ignorava, con sulle soglie trogloditi che ci offrivano acqua per puro istinto: una ragazza bella come una pastora di altre contrade, coi pantaloni rattoppati e il cappellone di paglia come una contadina del Texas ha versato acqua nella bottiglietta di Cottur, servendosi di un ramaiolo. Aveva i capelli neri e una falce sotto l’ascella...».
Il Giro correva via, moltiplicando paesaggi e città, delineando i caratteri di un’Italia che dal punto di vista demografico produttivo sembrava ancora quella dell’Ottocento. Certo, c’era la tragica eredità delle devastazioni seguite alla guerra: nel 1945 si contavano 2 milioni di case distrutte, 1.600.000 disoccupati, la produzione industriale ridotta a 1/3 di quella dell’anteguerra, quella agricola a 2/3. Ma i suoi tratti complessivi erano quelli di sempre, di un paese povero, contadino, con una base industriale molto ristretta, frammentato lungo molteplici linee di frattura, segnate dalla diversità strutturale tra Nord e Sud e che lasciavano intravedere “isole” di miseria anche all’interno delle zone più sviluppate. Gli italiani erano poveri, ma non tutti allo stesso modo: alla formazione del reddito nazionale, infatti, le regioni settentrionali concorrevano per il 60,5%, quelle centrali con il 17,8, quelle meridionali con il 14,4% e le isole per il 7,3%. Quanto all’analfabetismo, su una media nazionale pari al 12,9% della popolazione, gli analfabeti risultavano quasi scomparsi al Nord (con un minimo dell’1% in Trentino-Alto Adige, del 2,6% in Piemonte e del 2,7% in Lombardia), mentre al Sud sfioravano il 25% con punte massime in Calabria (31,8%) e in Basilicata(29,1%).
Il miracolo del 1945-48
Queste immagini di staticità e arretratezza, questo intreccio tra isole di benessere e oceani di povertà, di culture, dialetti, identità separate, erano la prova del fallimento del tentativo fascista di “nazionalizzare” gli italiani. E oggi, in chiave storiografica, rendono ancora più sorprendente il “miracolo” che si verificò tra il 1945 e il 1948: il 2 giugno del 1946 si andò a votare e, per la prima volta dopo venti anni di dittatura, tutti furono in grado di esprimere una libera volontà; votò circa di il 90% dell’elettorato, in una febbre di partecipazione politica scattata come una molla troppo a lungo compressa dalle strutture di un regime totalitario; si scelse nella Repubblica la nuova forma dello Stato, azzerando il peso di una monarchia troppo compromessa con il fascismo; ci si diede una Costituzione che ha rappresentato e rappresenta un “patto di cittadinanza” efficace e carico di valori civili in cui potersi riconoscere; nel 1948 l’indice della produzione industriale ritornò quello dell’anteguerra, certificando la piena ricostruzione, anche economica, dalle macerie del conflitto.
Lo spirito della Resistenza
Ci sono spiegazioni per questo “miracolo”? Si, e la prima è lo “spirito della Resistenza”. «Guardate le facce delle persone, i loro gesti, la loro attività - scrisse allora Carlo Levi - non hanno perso quello che avevano trovato nella Resistenza, e forse non lo perderanno per molto tempo. Sono vivi, attivi, tirano su muri diroccati, si sposano, fanno all’amore, cercano tutti i modi possibili, senza pigrizia e senza lamenti, di guadagnare la vita, di migliorarla e, con una incredibile rapidità, si sono dimenticati della guerra, della paura, del sangue, della servitù, del moralismo…».
La Resistenza nacque da una scelta. Nel crollo delle istituzioni e dello Stato, l’8 settembre del 1943 segnò per gli italiani una sorta di resa dei conti con se stessi. «Tutti a casa» fu lo slogan che segnò i comportamenti di quanti vissero quella data come un invito a rinchiudersi nel calore protettivo della famiglia, affollando una sorta di “zona grigia” che durante i venti mesi della lotta partigiana avrebbe avuto come unico obiettivo quello della sopravvivenza. Altri scelsero in modo opposto, interpretando l’8 settembre come la fine di una stagione di carestia morale e di avvelenamento delle coscienze. Fu la scelta consapevole di chi visse la Resistenza come il momento in cui a prevalere fu l’esigenza di non doversi più vergognare di se stessi, di riscattare, con quel gesto, venti anni di passività e di ignavia. Lo ha ricordato con forza Vittorio Foa. «Paion traversìe, sono opportunità»: fu il motto di Giambattista Vico che capovolse lo sgomento in voglia di azione, l’umiliazione in desiderio di riscatto. Tra le macerie dell’Italia fascista nacque un nuovo concetto di appartenenza nazionale, fondato su un “senso del dovere” che si sostituiva a ogni altro impulso, anche a quello della sopravvivenza; era quella l’ora in cui si era chiamati a testimoniare, come disse Eugenio Colorni, «il bisogno di non avere niente da rimproverarti, di essere in pace con la tua coscienza, presentabile di fronte a qualsiasi istanza giudicante». Fascismo e antifascismo si definirono come i due fronti opposti di una battaglia che avveniva tra due diverse concezioni del mondo: da una parte, il conformismo, la difesa dello stato di cose presenti, l’abitudine al compromesso e al tirare a campare; dall’altra, un imperativo categorico ad agire, la consapevolezza che solo nella lotta, nel conflitto, nell’opposizione si era in grado di realizzarsi compiutamente come uomini liberi. Era un’Italia guardata con sospetto e diffidenza da chi non ha mai capito perché tanti operai, tanti contadini, tante casalinghe abbiano affrontato - nel nome dell’antifascismo - lunghi anni di galera e i pericoli della lotta armata pur di non rassegnarsi al conformismo e all’opportunismo della maggioranza.
Dopo il crollo dello Stato fascista, venuta meno la sovranità statale, gli uomini che scelsero di impugnare le armi si trovarono in una condizione di «naturale assolutezza» e ognuno, nel momento di andare in banda, divenne “sovrano”. Nella scelta del singolo come atto sovrano erano racchiuse le potenzialità per produrre, attraverso la violenza, un nuovo ordine giuridico e politico. Fu l’emergere di un concetto nuovo di sovranità che aveva come titolare non più il popolo come entità unica (questo si era detto e scritto prima), ma tutti i singoli cittadini che lo compongono, con ciascun cittadino «che esercita la sovranità attraverso le sue libertà e i suoi diritti politici». Nella banda partigiana, prima ancora che nei CLN, un’intera generazione si affacciò così alla politica scavando nella propria coscienza, attingendo alle proprie motivazioni, proponendo la propria scelta come il fondamento di una rigenerazione collettiva. Queste istanze nell’esperienza partigiana si raccolsero intorno ai concetti chiave della partecipazione e dell’autogoverno; in uno stadio successivo, nelle prime formulazioni a caldo dei partiti, divennero il «via i prefetti» dei liberali, la «democrazia progressiva» dei comunisti, la «rivoluzione progressiva» dei democristiani, la «rivoluzione democratica» degli azionisti, la «repubblica socialista dei lavoratori» dei socialisti; trovarono poi la loro compiuta definizione nella «Costituzione dei partiti».
La Costituzione, eredità dell’antifascismo e della Resistenza
Fu così che la classe politica che allora fu chiamata alla guida del paese seppe farsi interprete con straordinaria efficacia dello “spirito della resistenza”. Da De Gasperi a Togliatti, da Nenni a Einaudi era quella una classe politica non ancora segnata da granitiche appartenenze partitiche: alle elezioni del 1946 per la Costituente, i deputati che provenivano dalle libere professioni erano il 43,7%, quelli reclutati negli apparati di partito il 18,4%. Nel 1953 alle elezioni politiche queste quote erano scese al 33,8% per i provenienti dalle professioni e salite al 26,2% per quelli provenienti dai partiti. Il tempo dei “muri” della guerra fredda arrivò presto. Ma quel “miracolo” sarebbe rimasto: nella nostra Costituzione, la tolleranza, la libertà, i diritti degli uomini, l’uguaglianza, la giustizia, il rispetto delle regole della convivenza civile, tutti gli elementi che definiscono il sedimento storico della democrazia, appaiono come caratteri permanenti, sottratti alle inversioni di rotta delle congiunture politiche, ai colpi di testa di effimere maggioranze governative. Questa Carta costituzionale è l’unica della nostra storia unitaria a scaturire da un’Assemblea costituente ed è stato l’antifascismo, attraverso la Resistenza e la Liberazione, a realizzare quello che era sempre stato il sogno inappagato di una democrazia compiuta.
L’eredità più significativa della Resistenza è proprio questa: aver indicato, attraverso un’Assemblea costituente votata dal 90% degli italiani, i lineamenti di una democrazia fondata sull’armoniosa convivenza tra i valori e le identità (la garanzia dei diritti individuali, sociali e politici) comuni alle tre grandi famiglie politiche e culturali che hanno fatto la storia del nostro paese, quella liberale, quella cattolica e quella del movimento operaio. Una democrazia che non può concedersi il lusso di essere “mite”, quasi che, contro le pulsioni populiste che periodicamente attraversano il nostro paese, le regole “normali” vadano potenziate attingendo alle risorse offerte proprio dagli “eccessi” di democrazia sedimentatisi intorno alle idee e alle identità dell’antifascismo.