Le peripezie di Etanolo
Da Etanolo a Etanale, l’avventuroso viaggio di una molecola
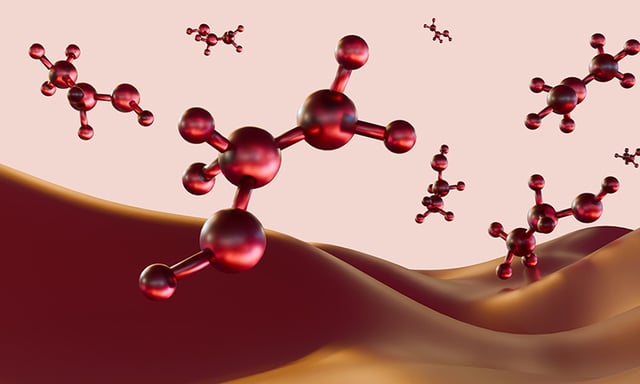
Questo racconto inaugura la serie dal titolo “Le molecole si raccontano”. Attraverso la tecnica dello storytelling si vuole porre l’accento sulle caratteristiche e sugli effetti di quattro sostanze molto diffuse tra i giovani: etanolo, caffeina, nicotina, fentanyl.
Pensiamo sia un modo originale e coinvolgente per ragionare insieme agli studenti e alle studentesse rispetto ai rischi derivanti dall’uso e dall’abuso di queste sostanze.
Mi chiamo Alcol Etilico oppure, se preferite, Etanolo, nome con il quale sono stato ufficialmente registrato. Sono una molecola molto piccola formata da due atomi di carbonio, sei di idrogeno e uno di ossigeno: C2H5OH è la formula chimica che mi rappresenta, ovvero la mia carta di identità.

Abito in 75cl di vino Barolo invecchiato quindici anni. Sono nato nei pressi di Cuneo in Piemonte, ma ora mi trovo in un’enoteca del centro Italia. La lontananza da casa non mi rende malinconico perché mi fanno compagnia miliardi di molecole di etanolo identiche a me. Qualsiasi studente di chimica saprebbe contarle tutte, ma non voglio scomodare nessuno di loro e nemmeno il buon caro e vecchio Avogadro. Tra l’altro, il Barolo in cui bazzico ha una concentrazione alcolica alquanto elevata, circa 14% V/V; perciò siamo molto più copiose di quelle presenti in una birra! Inoltre nel vino, oltre all’alcol e a tanta acqua, ci sono molte altre sostanze, come gli zuccheri, i polifenoli, i sali minerali e pure l’anidride carbonica, presente solo quando il vino è frizzante. Fra tutte preferisco la compagnia delle molecole di acqua: proprio per tale simpatia il vino è la trasparente e colorata soluzione alcolica che, assaporata con moderazione, nutre l’allegria, della quale peraltro sono l’unico responsabile. I meriti però non sono tutti miei; l’aroma, il gusto e il colore della divina bevanda dipendono da altre insostituibili comparse, come l’acido tartarico, che preserva il vino e il suo colore, e i polifenoli, molecole molto ingombranti, tipo i tannini (gli essiccatori del palato) e gli antociani (i pittori del vino).
Poiché la mia storia è lunga e chimicamente molto complessa, preferisco raccontarvela dall’inizio. Sono nato dal mosto dell’uva Nebbiolo, un’uva dai chicchi sferici blu scuri, opacizzati dalla pruina.

Il mosto contiene zucchero, un monosaccaride chiamato glucosio: è proprio dalla sua trasformazione (fermentazione alcolica) che sono venuto al mondo. Alcolica appunto perché, festeggiato da un eccezionale caloroso fermento, compaio io. Difatti il mosto ribolle: la temperatura sale e insieme a me compare anche l’anidride carbonica, un gas alquanto impetuoso.
La fermentazione si avvia grazie ai lieviti presenti nella buccia dell’uva: costoro senza ossigeno trasformano il glucosio in alcol, ricavandosi l’energia per vivere. È plausibile credere che il vino sia nato prima ancora dell’uomo: infatti le cellule animali hanno bisogno di ossigeno mentre i saccaromiceti (cioè i lieviti) no! Terminata la lunga e tumultuosa reazione (il Nebbiolo è un’uva molto zuccherina), ho trascorso un periodo di relativa quiete. All’inizio il vino è imbevibile: aspro, astringente, spigoloso e ruvido. Così lo etichetterebbero gli estimatori.
Nel vino Barolo che mi contiene, la maturazione è durata ben quindici anni. Prigioniero nella bottiglia inclinata e all’oscuro di tutto, credevo non solo di abbruttire e d’invecchiare ma addirittura di lasciarci la pelle. Meno male che in tutti questi anni mi sono distratto osservando i cambiamenti che la composizione della rossa bevanda ha subito. C’è stato, per l’appunto, un gran via vai di sostanze: chi è arrivato, chi ci ha lasciato, chi si è trasformato e chi, come me, è rimasto impassibile spettatore del progressivo miglioramento organolettico della dinamica soluzione. Dal legno della botte sono giunte nel liquido molte molecole di composti odorosi che hanno lasciato il segno nell’aroma finale. I tannini si sono trasformati e perciò l’astringenza del vino è diminuita; spesso nel modificarsi si sono polimerizzati o si sono legati alle proteine, diventando così ancora più voluminosi. Tant’è che spesso precipitavano sul fondo. Soprattutto in vicinanza delle doghe sono stato investito da molecole di ossigeno che, varcando il legno, sono riuscite dall’esterno a penetrare nel vino. L’ossigeno appariva molto inquieto poiché era alla continua ricerca di sostanze con cui attaccare briga. Malgrado i tentativi di eroica difesa, lui non ha desistito e con la complicità di qualche subdolo alleato, piano piano è riuscito a ossidare tantissimi polifenoli accontentando gli enologi: l’ossigeno ben dosato contribuisce all’evoluzione migliorativa di tutti quelli presenti all’inizio. E, dulcis in fundo, molte molecole mie gemelle nel corso degli anni si sono combinate con l’acido trasformandosi in esteri: molecole aromatiche che il naso del bevitore finale percepirà come un variegato bouquet olfattivo di note floreali, fruttate e speziate.
Dopo quindici anni di mutamenti, finalmente i sapori e gli aromi si sono arricchiti ed equilibrati, creando sfumature suggestive e originali tali da eleggere il Barolo a vino dalla spiccata personalità. A questo punto della storia mi trovo in un vino perfetto, in grado di appagare i palati e i nasi più esigenti, e sono in attesa che qualche cliente mi scelga.

Un giorno in enoteca entra una signora di mezza età. Sta cercando una bottiglia di Barolo speciale: un regalo per il compleanno del fidanzato. Il titolare le consiglia il Barolo. Impacchettato in un’elegante confezione, usciamo e dopo un breve tragitto arriviamo a casa del festeggiato. Il pregiato Barolo non è destinato a essere consumato subito; la bottiglia è riposta infatti nel ripiano più alto di una vetrinetta del salotto. Il trasloco mi ha reso piuttosto nervoso: temo per la mia vita il giorno in cui la bottiglia sarà stappata.
Invero la fatidica serata arriva. La casa si è riempita di gente e di allegria. Sulla tavola, apparecchiata con gusto, un ricco antipasto di formaggi di varie stagionature attende gli ospiti per l’assaggio. Il Barolo Riserva è posizionato al centro e io scruto sospettoso certi trasparenti calici, ampi e sottili. Il padrone di casa affida a un amico l’apertura della pregiata bottiglia. In un battibaleno scivolo nel calice di qualcuno degli invitati, dove meno oppresso, vengo però sballottato di qua e di là; infatti il tizio rotea il bicchiere e poi, di continuo, lo avvicina al naso. All’improvviso sento pronunciare all’unisono “cin cin” e nel contempo i tanti bicchieri si avvicinano sfiorandosi appena: un tintinnìo festoso amplifica l’allegria della comitiva. Intanto la paura è diventata angoscia e quando tutti accostano il calice alle labbra provo davvero terrore. In fretta lascio il luminoso vetro e vengo sbalzato in caduta libera di nuovo al buio. Al termine del capitombolo, uno spettacolo penoso mi agghiaccia: nello stomaco molte molecole di etanolo vengono aggredite da crudeli enzimi e periscono. Si sono ossidate in molecole di etanale, perdendo un paio di intimi amici: due atomi di idrogeno.
Io per fortuna riesco a proseguire indenne e mi ritrovo a circolare in un liquido rossastro e viscoso. C’è un gran affollamento di tizi a me sconosciuti (solo l’ossigeno mi è familiare) e in certi punti stretti scivolo così accelerato che quasi quasi rimpiango il ristagno nella bottiglia. Ma almeno sono ancora vivo!

Le scorribande in quel dedalo di tubi, tutti così stipati, sono durate circa un’ora. Mentre impaurito vortico, sento dire che non sarò accolto con cordialità da un tale di nome fegato. Infatti quando vi entro vengo anch’io assalito e convertito in etanale: sostanza antipatica ai più perché, in combutta con mio fratello minore Metanolo, induce i seccanti postumi della sbronza.
«Etanolo, etanale. Varia solo la desinenza, farà poca differenza!», starete pensando. Che grande abbaglio. I nomi sono simili ma non uguali e in chimica il suppergiù nasconde differenze enormi. Da alcol sono mutato in aldeide: è come il vino che degrada in aceto e il ferro in ruggine. Tutte conversioni irreversibili che separano nettamente il prima dal dopo.
Prima esistevo e dopo, ahimè, non più. La mia disavventura mi ha persuaso che il destino ineluttabile, comune a tutta la materia vivente e non, è il cambiamento. Tutto ha una scadenza e non potrebbe essere altrimenti: l’immutabilità contrasta la vita, la bellezza e persino la creazione di pezzi unici come il Barolo Riserva!
Referenze iconografiche: Love Employee / Shutterstock, Rudraksh Srivastava / Shutterstock, Minerva Studio / Shutterstock,
Thanakorn.P / Shutterstock, Nemes Laszlo / Shutterstock