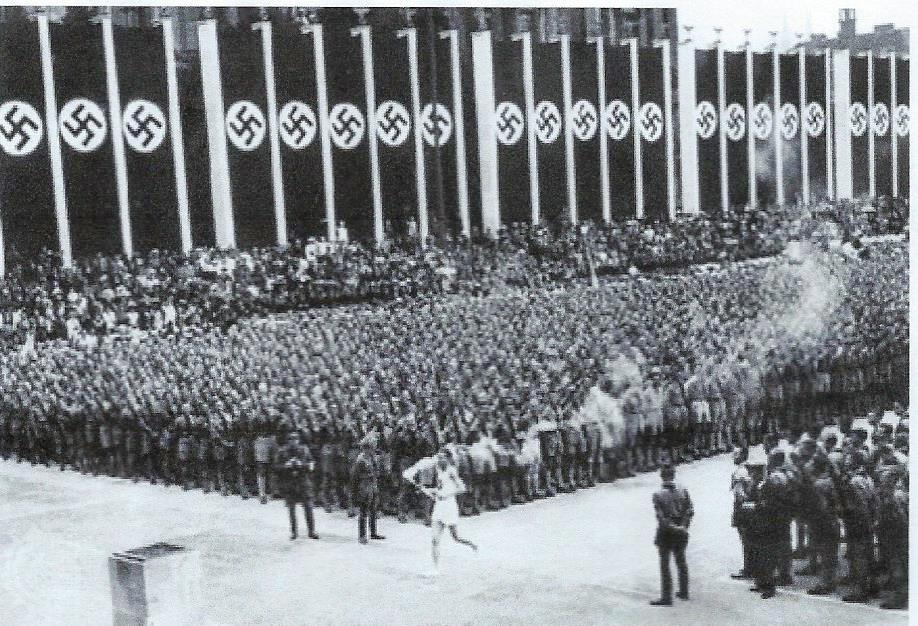La Riforma dello sport
I principali contenuti della legge n. 86/2019 e dei decreti attuativi

L’esigenza di introdurre una nuova organica disciplina del lavoro sportivo e di ammodernare la regolamentazione dell’intero comparto è alla base della Riforma dello sport, realizzata con la legge delega n. 86 del 2019 e i suoi cinque decreti attuativi.
Proponiamo questo articolo della professoressa Parisi, particolarmente utile anche in chiave di aggiornamento del corso Le Regole del gioco, di Maria Rita Cattani, per il triennio del Liceo scientifico a indirizzo sportivo.
La normativa antecedente la Riforma
L’atleta si impone quale soggetto d’eccellenza di tutto l’ordinamento del settore dell’attività sportiva: il professionismo stesso ha al centro lo sport, non il lavoro, e vive e si impegna totalmente per la performance, la gara e la vittoria. Da questo punto di vista, l’atleta professionista si distingue ben poco dall’amatore, dal dilettante: sono entrambi affiliati, inquadrati nella comunità sportiva.
Fino a tutto il secolo scorso l’attività sportiva, intesa come lavoro retribuito, costituiva un unicum, un’eccezione nel mondo del lavoro e delle leggi che lo disciplinavano, a volte, anche in senso peggiorativo. Non di rado, infatti, gli stessi provvedimenti normativi che in premessa riconoscevano la libertà dell’esercizio dell’attività sportiva - svolta in forma individuale o collettiva, professionistica o dilettantistica - ammettevano tuttavia il vincolo sportivo, che rappresentava una grave limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, poiché impediva a un giocatore il libero trasferimento presso un altro club senza il consenso della società sportiva di appartenenza.
La legge n. 91 del 1981 ha attribuito all’atleta professionista una nuova libertà, ponendo un termine alla durata del contratto, che non poteva superare i cinque anni. Inoltre, grazie alla nuova legge, in caso di cessione del contratto prima della sua scadenza, l’atleta (che in precedenza poteva essere trasferito da una società all’altra anche a propria insaputa) all’atleta doveva essere chiesto il consenso.
La legge n. 586 del 1996 ha stabilito che le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, individuate come vincolo sportivo, sarebbero state gradualmente eliminate entro i successivi cinque anni. La stessa legge, però, confermava il vincolo per tutti gli atleti dilettanti, riconoscendo alla società o alla associazione sportiva che, in virtù del tesseramento, aveva curato la formazione tecnica dell’atleta, il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico.
La nuova normativa
L’esigenza di una nuova organica disciplina del lavoro sportivo e del superamento di altri problemi e criticità veniva sempre più evidenziandosi all’inizio del 2000 e ha dato origine al lungo e travagliato percorso legislativo della Riforma dello sport. Tale Riforma nell’impianto originario avrebbe dovuto concretizzarsi in un organico Testo Unico, ma a causa di resistenze interne allo stesso mondo sportivo, abbandonata ogni ambizione di sistematicità, si è frammentata nei cinque decreti attuativi dell’originaria legge delega n. 86 del 2019. Finalmente, il 28 febbraio 2021, allo scadere della delega, sono stati emanati i cinque decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39, 40 in cui si concretizza in gran parte il riordino dell’intera normativa sportiva italiana. Essi introducono, tra l’altro, nuove regole concernenti il professionismo femminile e la parità di genere; tutele previdenziali per gli atleti; norme miranti alla sicurezza degli impianti (in particolare per gli sport invernali) e soprattutto la disciplina del lavoro sportivo. L’iter legislativo tormentato è testimoniato anche dalla scansione diversificata e differita dell’entrata in vigore di ciascuno dei citati provvedimenti attuativi.
Nel dettaglio, i cinque decreti riguardano:
- il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo (decreto legislativo n. 36);
- misure concernenti la rappresentanza degli atleti e delle società sportive e l’esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo n. 37, in vigore dal 1° gennaio 2023);
- il riordino e la riforma delle norme per la sicurezza degli impianti sportivi (decreto legislativo n. 38, in vigore dal 1° gennaio 2023);
- la semplificazione degli adempimenti per gli organismi sportivi (decreto legislativo n. 39, in vigore dal 31 agosto 2022);
- misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo n. 40, in vigore dal 1° gennaio 2022).
Anche alcune disposizioni del decreto legislativo n. 36, e precisamente gli articoli 10 (Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per il riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) si applicano dal 1° gennaio 2022, mentre l’entrata in vigore dei rimanenti articoli è differita al 1° gennaio 2023.
Finalità, valori e definizioni
Proprio il decreto legislativo n. 36 contiene gli elementi più innovativi dell’intera Riforma, della quale (all’articolo 3) emblematicamente espone finalità e obiettivi, come il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione sociale; la promozione dell’attività fisica adattata per mezzo della quale facilitare l’acquisizione di stili di vita corretti e funzionali alla conquista del benessere psico-fisico, così da consentire a ciascuno di praticare sport in modo sano e sicuro.
È notevole la revisione organica del lavoro sportivo che – tra l’altro - per la prima volta introduce tutele previdenziali sia nel settore dilettantistico che nel settore professionistico.
Il decreto n. 36, come tutti i principali provvedimenti di riforma che hanno interessato ambiti essenziali della società italiana, elenca, all’articolo 2, le definizioni autentiche dei principali termini e nozioni, che spaziano numerosi e particolareggiati in tutti i campi, quasi nell’assillo di non tralasciare ambiti o soggetti bisognosi di cura, tutela e nuovo interesse. Ciascuna definizione - in rigoroso ordine alfabetico - è in sé un programma ispirato a principi e valori di democraticità, uguaglianza e solidarietà, a cominciare dalla definizione di sport, che significativamente, fin dall’inizio, basa ogni forma di attività sportiva sul rispetto delle regole: per attività sportiva, infatti, si intende qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli. È invece ben distinta l’attività fisica o motoria, che comprende qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo, mentre l’esercizio fisico strutturato è specifico dei programmi di attività fisica pianificati sulla base delle condizioni fisiche dei singoli soggetti.
Analogamente, il termine palestra diventa, per definizione, un’endiadi: palestra della salute, quasi a evocare il detto mens sana in corpore sano: essa è, per la Riforma, la struttura di natura non sanitaria, sia pubblica sia privata, in cui vengono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata.
L’attività fisica adattata
Con l’espressione attività fisica adattata (AFA), il Legislatore del decreto n. 36 indica i programmi di esercizi fisici la cui tipologia e intensità sono definite mediante l’integrazione professionale organizzata tra medici generici, pediatri e medici specialisti, e sono calibrate in base alle condizioni funzionali delle persone a cui sono destinati, che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le palestre della salute, per migliorare la qualità della vita e favorire la socializzazione.
Il decreto specifica che i corsi e le attività motorie e sportive offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.
Inoltre, nelle strutture, deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, in un’ottica di prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation.
I ruoli e le responsabilità
Altre definizioni specificano ruoli e responsabilità, ad esempio:
- del direttore di gara, il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- del direttore sportivo, il soggetto che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva; la gestione dei rapporti tra società, atleti e allenatori; la conduzione di trattative con altre società sportive riguardanti il trasferimento di atleti; la stipulazione dei contratti e il tesseramento.
La Sport e salute S.p.A.
L’ultima delle definizioni riguarda la Sport e salute S.p.A., la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura di servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o da altra autorità politica da lui delegata.
La Sport e salute S.p.A. nasce il 16 settembre 2002 come CONI Servizi S.p.A., una società per azioni a totale partecipazione pubblica. Essa è titolare di tutti i beni del CONI e promuove la realizzazione di opere pubbliche inerenti allo sport, raccogliendo sponsorizzazioni tramite bandi di gara.
Il decreto n. 36 ribadisce, nel rispetto degli articoli 2, 3, 35, 41 e 117 della Costituzione, la competenza legislativa dello Stato in materia di istruzione, di previdenza sociale, di tutela della salute e in materia finanziaria e tributaria.
La nozione di lavoratore sportivo
L’articolo 25 del decreto n. 36 riformula la figura del lavoratore sportivo, che comprende ora anche gli atleti e i soggetti operanti nel settore dilettantistico. Sono, infatti, lavoratori sportivi: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano un’attività sportiva retribuita, al di fuori delle attività amatoriali.
Per l’articolo 29 del decreto, le attività amatoriali sono le prestazioni di chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro per promuovere lo sport. Tali attività comprendono, oltre allo svolgimento diretto dell’attività sportiva, anche la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti, e non possono essere retribuite nemmeno da chi ne trae beneficio. I prestatori di attività amatoriali possono invece fruire di premi e compensi occasionali in base ai risultati ottenuti nelle competizioni, di indennità di trasferta e di rimborsi spese.
Il lavoro sportivo
L’attività sportiva può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409 del Codice di procedura civile. Anche nel lavoro sportivo, la collaborazione deve essere organizzata solo dal collaboratore stesso. I prestatori di collaborazione coordinata e continuativa potranno trovare tutela con la prevista iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Il rapporto di lavoro sportivo è subordinato se l’attività sportiva è prevalente o continuativa. Ha natura di lavoro autonomo, se è presente almeno uno dei seguenti requisiti:
- se l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- se lo sportivo non è vincolato da un contratto alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento;
- se la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le otto ore settimanali, oppure i cinque giorni ogni mese, o i trenta giorni ogni anno.
I lavoratori sportivi professionisti saranno iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall’INPS, che sarà rinominato Fondo pensione dei lavoratori sportivi. Ad esso potranno iscriversi anche i lavoratori dilettanti, se subordinati, che fruiranno in tal modo di un ampliamento della loro tutela.
La Riforma dello sport, inoltre, promuove le pari opportunità nelle prestazioni di lavoro sportivo; tutela il diritto dei minori alla pratica sportiva e il connesso diritto al necessario potenziamento delle strutture inserite negli ambienti scolastici; garantisce la pratica sportiva dei cittadini con disabilità per assicurarne il pieno inserimento nella società civile; protegge la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive e tutela la sicurezza e la dignità di tutti i lavoratori dello sport, nel rispetto della specificità dell’attività sportiva.
Il tesseramento degli atleti minorenni
In base all’articolo 16 del decreto n. 36 la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale, che deve tener conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. La richiesta di tesseramento può essere presentata disgiuntamente da ciascuno dei genitori, ma deve rispettare la volontà del minore che, se ha compiuto 12 anni, deve prestare personalmente il proprio consenso. In caso di disaccordo, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, e sarà il giudice a decidere in materia.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in commento, saranno introdotte ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva; è prevista anche la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, per prevenire ogni tipo di abuso e di violenza e a protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi.
Il decreto n. 36 prevede, inoltre, ai fini del tesseramento, una sostanziale equiparazione tra minori con cittadinanza italiana e minori ancora privi di cittadinanza italiana, purché questi ultimi, anche se non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano.
Il vincolo sportivo nel settore professionistico
Il vincolo sportivo è il legame che, a seguito del tesseramento, unisce il calciatore alla società e in base al quale l’atleta è tenuto a svolgere la propria attività solo all’interno del club a cui si è tesserato.
Tali limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, in base all’articolo 31 del decreto in discorso, saranno definitivamente eliminate a partire dal 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere una disciplina transitoria per diminuire gradualmente la durata massima del vincolo sportivo.
Attualmente il tesseramento di un minore, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, ha durata annuale, con la conseguente possibilità di svincolo al termine della stagione, dopo il 30 giugno di ogni anno. Invece il tesseramento con un club professionistico dell’atleta che ha compiuto i quattordici anni comporta il sorgere di un vero vincolo pluriennale, che perdura fino al termine della stagione sportiva che inizia dopo il compimento dei diciannove anni. Nel periodo che va dai quattordici ai diciannove anni lo svincolo è possibile solo per iniziativa della società di appartenenza o se la società viene esclusa dal campionato o subisce la revoca della affiliazione.
Il vincolo sportivo nel settore dilettantistico
Nel settore dilettantistico l’atleta minorenne può tesserarsi solo annualmente nel periodo che va dai quattordici ai sedici anni. Dopo i sedici anni il tesseramento diviene obbligatoriamente pluriennale, e il giovane può svincolarsi solo al termine della stagione durante la quale raggiunge il venticinquesimo anno di età.
Il vincolo sportivo viene tuttora considerato un istituto anacronistico ed è ritenuto da alcuni addirittura anticostituzionale, perché impedisce ai giovani di scegliere con quale società giocare, costringendo così molti ad abbandonare l’attività agonistica.
A partire dal 1° luglio 2022, con l’abolizione del vincolo sportivo, anche l’atleta dilettante, come il professionista, sarà libero di trasferirsi senza il consenso del club di appartenenza: ma se si tratta del suo primo contratto di lavoro sportivo, il nuovo club dovrà riconoscere alla società presso la quale l’atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile un premio di formazione tecnica.
I diritti degli animali impiegati in attività sportive
Gli articoli dal 19 al 24 del decreto sono dedicati alla tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive. Merita una menzione simbolica la definizione del cavallo atleta, che testimonia l’intento di riconoscere la dignità e il valore di ogni soggetto animato a cui compete rispetto. In precedenza e altrove definito oggetto animato, qui è descritto come equide registrato, non destinato a fine carriera alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell’attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri.
L’articolo 22 elenca i requisiti che congiuntamente conducono alla definizione del cavallo atleta:
- è necessario che risulti come equide registrato nel Documento di identificazione conforme al Regolamento (UE) n. 262/2015;
- deve essere dichiarato non destinato alla produzione alimentare, anche dopo la cessazione dell’attività sportiva;
- deve essere iscritto al Repertorio dei cavalli atleti presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o altro Ente di Promozione Sportiva, come deve risultare dallo stesso Documento di identificazione.
Nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri devono essere garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico.
È oggetto di tassativo divieto sopprimere gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento per ragioni umanitarie.
La tutela degli interessi dei tifosi
È di grande rilievo la norma contenuta nell’articolo 13, che prevede l’istituzione, all’interno degli Statuti delle società sportive professionistiche, di un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. I componenti di tale organo sono eletti ogni cinque anni dai tifosi abbonati a ciascuna società sportiva. La votazione avviene con sistema elettronico, secondo un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società, che deve anche stabilire le regole in materia di privacy e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza.
La parità di genere
Per promuovere la parità di genere è istituito un Fondo per il professionismo negli sport femminili, e tutte le Federazioni nazionali che intendano accedervi dovranno deliberare il passaggio dei campionati femminili al professionismo entro il 31 dicembre 2022.
Il decreto n. 36 all’articolo 40 prevede, inoltre, che la parità di genere, in ogni struttura, deve essere promossa a tutti i livelli dalle Regioni, dalle Province autonome e dal CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, favorendo l’inserimento delle donne anche nei ruoli di gestione e di responsabilità all’interno delle organizzazioni sportive.
Sarà il CONI a controllore l’effettivo rispetto della parità di genere, in quanto è tenuto a vigilare sull’osservanza di tale principio da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
Atleti paralimpici e pari opportunità
La Riforma dello sport offre agli atleti paralimpici la possibilità di accedere e tesserarsi con i vari Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato: infatti, ai sensi degli articoli 46 e ss., sono istituite le Sezioni Paralimpiche presso i Gruppi Sportivi delle Fiamme Azzurre, delle Fiamme Oro e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
È sancito anche il principio del reimpiego degli atleti non più idonei all’attività sportiva paralimpica nei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza della parità di trattamento economico, giuridico e previdenziale, unito al riconoscimento della pari progressione di carriera tra atleti disabili e atleti normodotati.
La formazione dei giovani atleti
Il legislatore della Riforma mira al perfezionamento della formazione dei giovani atleti, al fine di garantire loro una ottimale crescita sportiva, culturale ed educativa, ma anche una preparazione professionale che favorisca l’accesso o il prosieguo dell’attività lavorativa alla fine della carriera sportiva.
Per agevolare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro è prevista per le società e le associazioni sportive la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per il conferimento di un diploma professionale, di un diploma di istruzione superiore e di un certificato di specializzazione tecnica superiore.
È notevole, inoltre, l’introduzione di ulteriori disposizioni concernenti i laureati in Scienze motorie. Infatti, l’articolo 41 istituisce le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.
La professione di chinesiologo di base
Per l’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22).
L’esercizio della suddetta attività professionale ha come oggetto:
- la conduzione, la gestione e la valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo, finalizzate al mantenimento e al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età, tramite la promozione di stili di vita attivi;
- la conduzione, la gestione e la valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico;
- l’attività di personal training e di preparazione atletica non agonistica.
La professione di chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate
Per l’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67).
L’esercizio di questa attività professionale ha per oggetto:
- la progettazione e l’attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti di varie fasce d’età e in diverse condizioni fisiche;
- l’organizzazione e la pianificazione di particolari attività e stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico;
- la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all’ottimizzazione dell’efficienza fisica;
- la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone con disabilità.
La professione di chinesiologo sportivo
L’attività professionale di chinesiologo sportivo richiede il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68) e ha per oggetto:
- la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, presso Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati;
- la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all’agonismo individuale e di squadra.
La professione di manager dello sport
L’attività professionale di manager dello sport richiede il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47) e ha per oggetto;
- la programmazione e la gestione di impianti sportivi;
- la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative;
- l’organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive.
Le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l’individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport sono dettate d’intesa con il Ministro dell’Università e della ricerca.
Referenze iconografiche: CrispyPork/Shutterstock