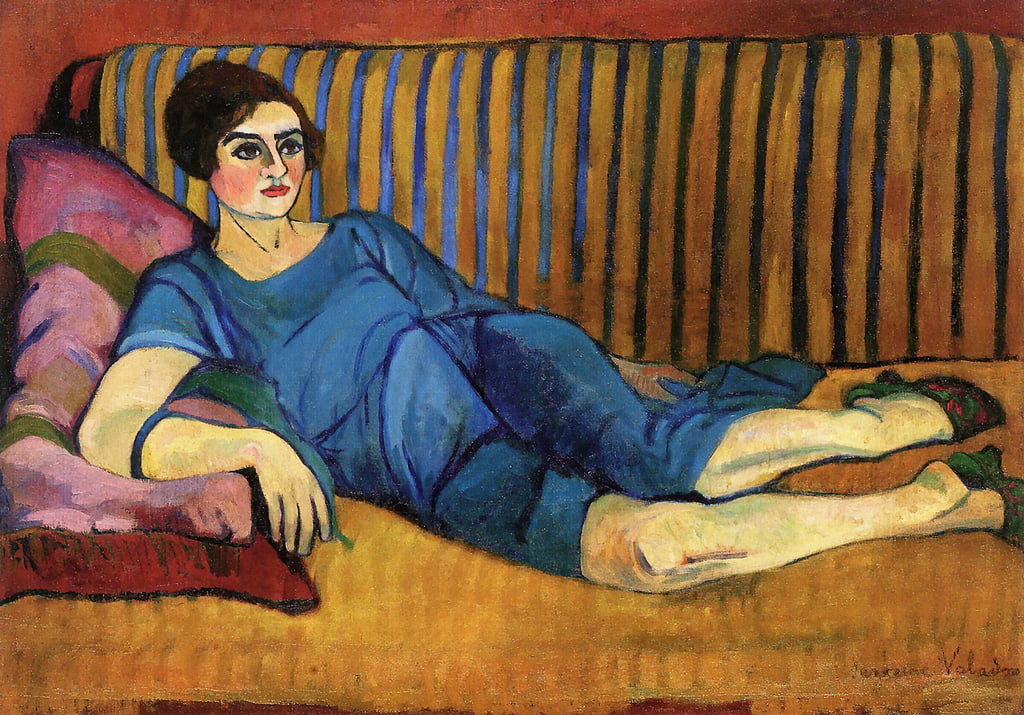Le scarpe: con il tacco e senza, colorate o tinta unita, piene di ricami o spoglie, chiuse o aperte. Poi sandali, stivaletti, mocassini, ciabatte, zoccoli, calzature da lavoro, ballerine, scarponi. Vediamo e indossiamo moltissime scarpe ogni giorno. Ci proteggono dall’asfalto bollente in estate, dal freddo della neve in inverno. Insomma, ci sostengono.
Ma, chiediamoci questo: saranno tanto importanti anche nell’arte, le scarpe?
Interroghiamo alcuni maestri indiscussi dell’arte.
Togliersi le scarpe prima di entrare
Per esempio potremmo iniziare con Raffaello Sanzio che, poco più che ventenne, nel 1504, dà vita a un’opera divenuta famosissima. Il suo titolo? Si chiama Sposalizio della Vergine ed è un dipinto su tavola in cui Raffaello ha raffigurato un episodio della tradizione cristiana: il matrimonio (lo “sposalizio”) di Maria, mamma di Gesù, con Giuseppe. Il matrimonio avviene a Gerusalemme, davanti al Tempio della città, dipinto sullo sfondo. Proviamo a guardare bene i dettagli.

Raffaello Sanzio, Sposalizio della Vergine, 1504, olio su tavola, 170x117 cm, Pinacoteca di Brera, Milano.
Vedete? Nel primo piano della composizione troviamo il sacerdote del Tempio che, al centro della scena fra i due futuri sposi, china il capo alla sua sinistra. Un gesto naturale, aggraziato, che dona movimento. Non trovate anche voi? Alla destra del sacerdote vediamo Maria: abito rosso, manto blu e una fascia bianca, talmente leggera che Raffaello ci racconta quanto è sottile con un gioco di trasparenze. Alla sinistra invece vediamo Giuseppe, un uomo maturo, vestito di giallo e verde, attorniato da altri uomini. Guardiamo però un po’ meglio. Chi c’è dietro Giuseppe? Avete notato? C’è un uomo che prova a piegare un bastoncino con le mani e che, guardandoci, ci invita a immaginare di entrare nell’opera. Come se fossimo chiamati anche noi a partecipare al matrimonio. Di fronte a lui, un altro uomo prova a spezzare il proprio bastoncino sottile. Per capire questo gesto dobbiamo tornare indietro nel tempo e provare a cercare qualche informazione in un testo: il Vangelo di Giacomo, che racconta le vicende legate ai genitori di Gesù e ai primi anni della sua vita. In questo testo si dice che il sacerdote del Tempio di Gerusalemme avesse riunito i pretendenti di Maria chiedendo loro di portare un rametto. Disse che la giovane avrebbe sposato l’uomo a cui il ramo fosse fiorito. L’unico a fiorire fu proprio il ramo di Giuseppe. Il giovane in primo piano prova quindi a rompere il suo bastoncino perché è deluso: non è stato scelto.
Mentre gli sposi si scambiano gli anelli, il nostro occhio cade su un piccolo dettaglio, però importantissimo. Avete visto anche voi? Giuseppe è a piedi nudi: si sarà dimenticato le scarpe? O forse Raffaello ci vuole dire qualcosa di diverso? Tutti hanno le scarpe, tranne lui. Ci serve un altro libro per capire. Questa volta, la Bibbia: nella Bibbia si dice che il patriarca Mosè era stato invitato da Dio a togliere i sandali per non calpestare il luogo sacro del roveto ardente sul Monte Sinai, dimostrando così il suo rispetto. Durante una cerimonia sacra quindi, per rispettare il luogo e soprattutto per accostarsi a Dio, bisogna togliere le scarpe.
Adesso possiamo rispondere: Giuseppe non si è dimenticato le scarpe, ma probabilmente, dopo averle tolte, le ha messe in disparte. Vogliamo un’ulteriore certezza? Anche Raffaello ha studiato, sapete? Il suo maestro si chiamava Pietro Perugino e, prima di Raffaello, aveva dipinto uno Sposalizio della Vergine. Ci aveva messo circa quattro anni per realizzare l’opera, dal 1501 al 1504.

Pietro Perugino, Sposalizio della Vergine,1501-1504 ca, olio su tavola, 234x185 cm, Musée des Bæux-Arts, Caen (Francia).
Osserviamo la composizione: c’è il sacerdote, c’è il Tempio sullo sfondo, ci sono i due gruppi di uomini e donne che vediamo anche nel dipinto di Raffaello, ci sono dei bastoncini senza fiori e quello di Giuseppe fiorito. E le scarpe? No, non ci siamo sbagliati. Le scarpe non ci sono neanche qui!
Peccatori in una scarpa
Cosa succede però se qualcuno non toglie le scarpe per rispettare il luogo sacro? Ce lo racconta il pittore fiammingo Hieronymus Bosch in un’opera del 1486 circa dal titolo Trittico del Giudizio Finale. Aguzzate la vista! In mezzo a tutti i dettagli provate a cercare una sorta di zoccolo olandese dalle tinte rosacee.

Kieronymus Bosch, Trittico del Giudizio Universale, 1501-1504 ca, olio su tavola, 234x185 cm, Musée des Bæux-Arts, Caen (Francia).
Lo vedete? E dentro, cosa notate? È uno zoccolo strano, che, trasformato in barchetta, sembra traghettare delle anime. Tutti i personaggi che vediamo nell’opera, nel pannello centrale, hanno una caratteristica: sono peccatori e peccatrici e vengono ugualmente puniti per i loro peccati nel giorno del Giudizio Universale. Guardiamo anche i pannelli laterali. Da un lato troviamo le anime che, in una barca con una tenda, vengono condotte in Paradiso mentre, dall’altro lato, ci sono le anime dei peccatori che bruciano all’Inferno. Il Giudizio incombe su ciascun personaggio rappresentato. Vivi e morti vengono, nell’opera, giudicati da Gesù. La scarpa gigante diventata barchetta è, in questo dipinto, il simbolo di chi non ha rispettato il sacro. Insomma, tutto il contrario del buon san Giuseppe!
La bellezza di un paio di scarpe
Siamo passati da un personaggio senza scarpe nei dipinti di Perugino e Raffaello a uno zoccolo-barchetta gigante che trasporta i peccatori nel Trittico di Bosch. Cosa ci dovremmo aspettare ora?
Un dipinto con solo scarpe! Questa volta dobbiamo muoverci avanti nel tempo rispetto alle opere precedenti e finire nella mente di uno degli artisti più dibattuti di sempre: Vincent van Gogh. Su di lui, sono stati scritti fiumi d’inchiostro! Pensate che realizzò molte opere con protagoniste le scarpe. Era un artista che amava la natura, i campi coltivati, le viti, i frutteti, le radici degli alberi. Aveva passato un breve periodo di tempo presso una famiglia contadina: li osservava, li dipingeva mentre cenavano con la zuppa di patate e cercava di cogliere le particolarità dei loro indumenti. Vincent guardava i contadini lavorare la terra: voleva raccontare attraverso la pittura il mutare della natura e la forza dell’uomo che la lavora. Nel 1886 dipinse Un paio di scarpe.

Vincent van Gogh, Un paio di scarpe, 1886, olio su tela, 37x45 cm, Museo Van Gogh, Amsterdam.
Avete notato però una cosa strana? Sono due scarpe, ma entrambe sinistre! Logore, sudicie, deformi, abbandonate, rappresentano la fatica del mondo contadino. Per Vincent, figlio di un pastore protestante, anche le scarpe, come la natura, rappresentavano qualcosa di sacro. Vincent non dipingeva le immagini della tradizione cristiana (come lo Sposalizio che abbiamo analizzato), bensì era affascinato dalla natura e da tutte le sue molteplici forme. Per lui, Dio si trova in tutte le cose del mondo, della natura, della vita. Anche in un paio di scarpe abbandonate.
Avete visto quante scoperte si possono fare grazie all’arte, sulle scarpe?
Referenze iconografiche: Africa Studio/Shutterstock, Wikimedia Commons